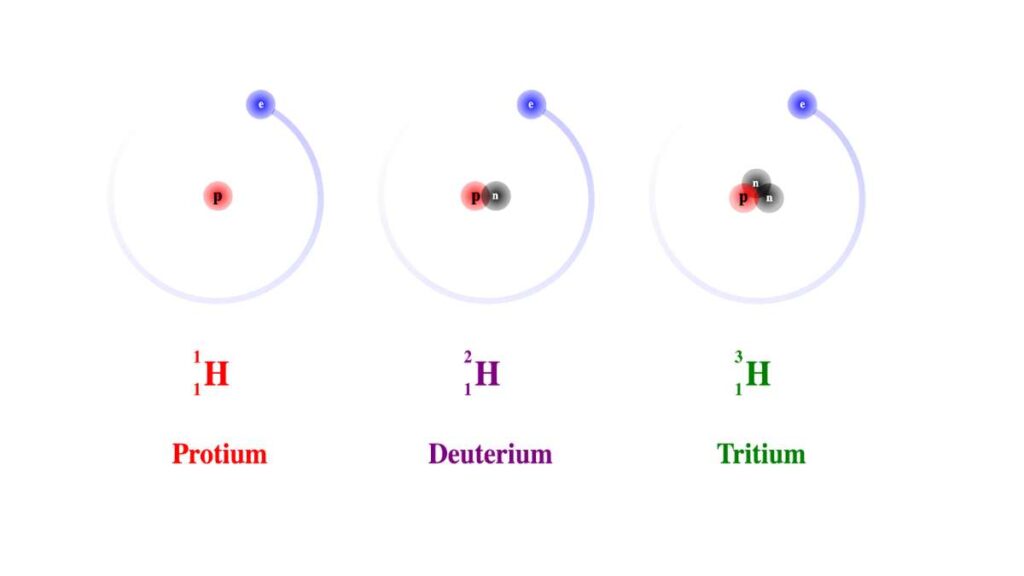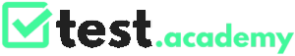Isaac Newton e lo studio della Meccanica
Quando sentiamo nominare questo celebre scienziato inglese la prima cosa a cui pensiamo è la mela che si racconta lo portò a definire la teoria di gravitazione universale. Di fatto però questa non è che uno dei tanti contributi che diede alla Fisica, tra cui ci furono anche le basi della cosiddetta Meccanica Newtoniana. Si tratta della branca che comprende la dinamica, la statica e la cinematica, ovvero ciò che riguarda posizione e movimento dei corpi.
Di seguito esamineremo i principi che definì relativamente alla Dinamica, che pur avendo ormai più di tre secoli continuano a essere fondamentali per la comprensione del movimento dei corpi.
La stesura dell’opera Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
- De motu corporum (parte prima). Tradotto signifcia “Riguardo il movimento dei corpi”, ed è il testo in cui sono descritti i tre principi della Dinamica. A questa trattazione si aggiungono le deduzioni che derivano dalla formulazione di queste leggi.
- De motu corporum (parte seconda). Data l’estensione del trattato questa prima esposizione risulta a sua volta suddivisa in due libri. In questa seconda parte si trova la descrizione in forma matematica del moto dei corpi e l’accenno al calcolo della velocità del suono.
- De mundi systemate. Quest’ultima parte del trattato di Isaac Newton tratta concetti molto diversi rispetto a quelle viste prima. Come dice il titolo è dedicata alla gravitazione universale e alla fisica dei pianeti del Sistema Solare. Ci sono osservazioni che riguardano anche i satelliti, come la Luna, e altri corpi celesti tra cui le comete.
La prima legge di Isaac Newton
Nella realtà quando un corpo è in movimento a un certo punto si ferma perché è presente la forza di attrito a contrastare il moto. Per esempio quella esercitata dall’aria finché il mezzo si muove in ambiente terrestre oltre a quella contro il materiale della superficie su cui si sposta. Questo può essere radente quando deriva dallo strisciamento del corpo, volvente quando questo si sposta rotolando o viscoso se il corpo si muove in un fluido (in acqua per esempio).
Lo scenario descritto da Isaac Newton è quello di un oggetto che si muove o si trova fermo nel vuoto, come può avvenire nello spazio cosmico. Vista l’enorme rarefazione dell’aria l’attrito presente è trascurabile.
La seconda legge della Dinamica
Nei libri è spesso riportata anche come principio di conservazione o di proporzionalità. Afferma che la forza che agisce su un corpo risulta direttamente proporzionale sia alla sua massa che alla sua accelerazione. In quanto grandezza vettoriale la forza ha anche una direzione e un verso, che sono gli stessi dell’accelerazione.
Volendo possiamo riassumere la seconda legge di Isaac Newton con la formula F = m x a. Da qui possiamo dedurre anche che l’accelerazione è inversamente proporzionale alla massa del corpo. Si può anche affermare che questa seconda legge rappresenti un caso particolare del principio d’inerzia visto prima. Vale a dire quello in cui l’accelerazione è pari a zero.
Poiché la forza deriva dal prodotto della massa e dell’accelerazione la sua unità di misura è il kg x m/s2, che coincide appunto con il Newton (N).