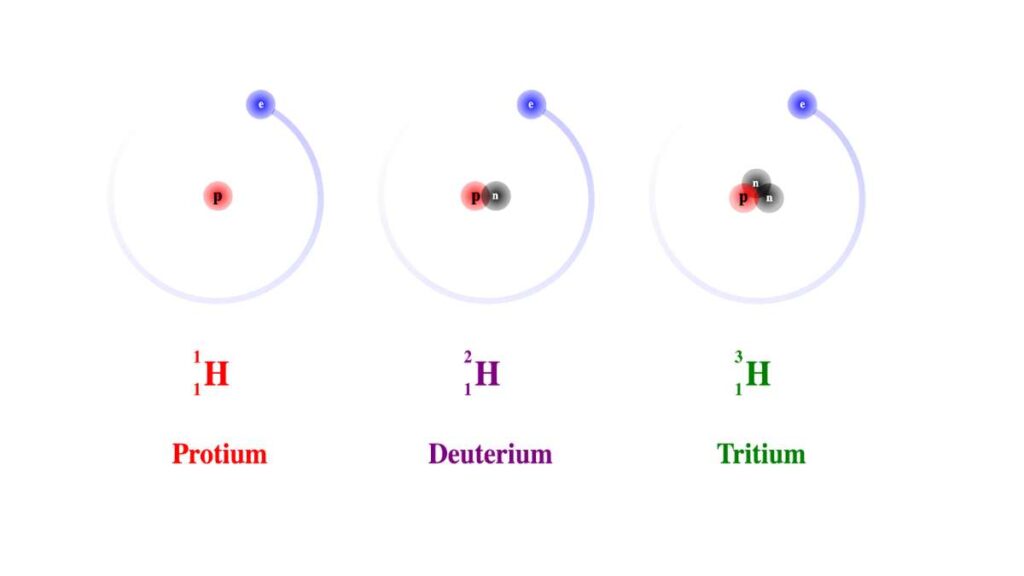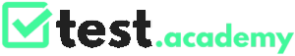Cosa significa omeostasi
Questo termine è di derivazione greca e significa “stessa posizione”. A coniarlo fu Walter Cannon, un fisiologo statunitense che detenne una cattedra all’Università di Harvard fino al 1942. Per la precisione se ne servì per indicare la tendenza di un organismo a mantenersi stabile, condizione necessaria per la sopravvivenza e in particolare quando ci sono variazioni nell’ambiente.
Questo bisogno di equilibrio accomuna ogni tipologia di organismo, da quelli più semplici e unicellulari fino ai mammiferi e all’uomo. I parametri necessari per la stabilità di un essere vivente sono vari, e li vedremo di seguito.
I principali parametri che regolano l’equilibrio del corpo
All’interno dell’omeostasi rientrano tutti vari processi con cui l’organismo cerca di regolarsi per poter sopravvivere mantenendo costanti alcune condizioni. Tra queste una delle prime che possiamo nominare è la temperatura interna del corpo, che per noi è ideale quando oscilla tra i 35,2 i 36,9 °C.
Questa può fluttuare leggermente in base al momento della giornata e a seconda del fatto che si sia a digiuno si abbia appena mangiato.
Un altro parametro fondamentale da tenere sotto controllo è il pH ematico.
Questo risulta leggermente alcalino, dato che i valori considerati nella norma sono intorno a 7,3 – 7,5. In caso il pH ematico superi questa soglia si parla di alcalosi metabolica, mentre al di sotto andiamo incontro all’acidosi. Entrambe queste condizioni possono comparire in seguito a problemi di respirazione o di origine metabolica.
L’omeostasi del nostro corpo prevede anche di mantenere stabile la glicemia nel sangue. A digiuno questa dovrebbe essere al di sotto dei 100 mg/dL, sopra la quale abbiamo l’iperglicemia. Se questa raggiunge valori troppo alti si rischia il coma diabetico, ma anche valori troppo bassi sono pericolosi. Quando la glicemia scende sotto i 59 mg/dL invece si verifica l’ipoglicemia, che può portare al collasso.
Altri parametri fondamentali per mantenere l’organismo in condizioni di equilibrio sono il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Per la loro regolazione il corpo ricorre a due strategie principali: il feedback negativo e il feedback positivo.
L’omeostasi e il sistema a feedback negativo
In questo processo dell’omeostasi intervengono due ormoni fra loro antagonisti, che sono la calcitonina e il paratormone. La prima stimola l’assorbimento del calcio a livello osseo, il secondo provvede al suo rilascio quando i livelli ematici scendono al di sotto della soglia di equilibrio.
La regolazione a feedback positivo
L’altro processo che possiamo trovare nel nostro organismo per mantenere l’omeostasi funziona inversamente rispetto al feedback negativo.
In un processo biochimico che sfrutta questa regolazione infatti è il prodotto stesso che accelera la reazione che porta alla sua sintesi. Più questo aumenta dunque maggiore velocità avrà il processo biochimico.
Un esempio di sistema a feedback positivo lo troviamo nella regolazione di un enzima coinvolto nella glicolisi, ossia la piruvato chinasi.
Il suo attivatore è il fruttosio -1,6-bifosfato, un prodotto intermedio prodotto sempre durante la glicolisi. Più aumenta la sua concentrazione quindi più efficiente risulterà la via glicolitica del nostro metabolismo.
L’omeostasi a livello cellulare
Finora abbiamo parlato del mantenimento delle condizioni di equilibrio a livello dell’organismo, ma ogni cellula deve a sua volta regolare diversi parametri per restare in vita.
Per cominciare c’è il pH del citoplasma, mantenuto stabile grazie a dei sistemi tampone. Se arriva a un altro valore di acidità infatti è possibile che le strutture interne come gli organelli e il citoscheletro si deteriorino rapidamente. Basti pensare al ruolo dei lisosomi, che sciolgono grazie alle sostanze acide contenute al loro interno gli organelli danneggiati.
Per l’omeostasi cellulare è importante anche regolare la concentrazione di diversi altri ioni presenti nel citosol, detta anche forza ionica.
A questo scopo contribuiscono le pompe ioniche presenti sulla membrana plasmatica. Anche qui possiamo fare l’esempio del calcio (Ca2+), che all’interno del citosol è di circa 10−7 M, mentre nell’ambiente extracellulare è molto più abbondante (2,5 mM).
Nella sua regolazione hanno un ruolo importante gli scambiatori sodio/calcio (Na+/Ca2+) che mediano l’estrusione dello ione dal citoplasma all’esterno. Il suo trasporto invece coinvolge le pompe calcio ATP-dipendenti. Per altri ioni può essere sufficiente la diffusione semplice attraverso la membrana plasmatica per mantenere le concentrazioni in equilibrio.
L’equilibrio dinamico dell’organismo
Dato che anche nell’arco di poche ore si possono avere simili variazioni possiamo dire che il nostro corpo si trova in uno stato di equilibrio dinamico. Non c’è mai una condizione pienamente stabile, ma si verificano costanti aggiustamenti dei parametri interni attraverso i meccanismi descritti in precedenza.